<<Il successo di un museo non si valuta in base al numero di visitatori che vi affluiscono, ma in base al numero dei visitatori ai quali si è insegnato qualcosa…questo è il museo […]. Se non possiede tali caratteristiche è solo una sorta di ”mattatoio culturale”>>
–Georges-Henri Rivièr

Il termine greco ”hybris” indicava un atteggiamento di superbia tale da provocare sovente l’ira e il conseguente castigo divino.
Poniamoci una domanda: cosa sarebbe accaduto se Pindaro si si fosse innalzato in voli troppo audaci?
Il rischio sarebbe stato di ritrovarsi come Icaro, in caduta libera e sfracellato al suolo.
I voli pindarici nei quali sembra essersi imbattuta l’arte -specie in Italia- si macchiano di superbia -o meglio strafottenza, o meglio ancora banale ingenuità- e rischiano di trasformarsi in un volo a planare, le conseguenze del cui schianto già si vanno delineando.
Basterebbe l’affermazione di Angela Vettese, secondo la quale l’arte è riflesso del proprio tempo, a farci accomodare sulle sponde del fiume in attesa di veder scorrere dinanzi a noi i resti di uno sciacallaggio di cui tutti sono -e siamo- responsabili.
Dall’accozzaglia di eventi promossi dal Macro Asilo sino alle mostre tematiche ed emozionali, tutto concorre ad un becero fenomeno di spettacolarizzazione dell’arte simile ad uno show, incrocio tra una serata al luna park e una passeggiata domenicale ad un centro commerciale.
C’è una falla all’interno del sistema dell’arte che mina il corretto funzionamento dei suoi ingranaggi, i quali, ormai privi di un rapporto di consequenzialità, girano ognuno per proprio conto.
A complicare il quadro la svolta fringe dell’arte -per utilizzare un’espressione formulata dal compianto Perniola– culminata nella libera parificazione, da un punto di vista della proposta, tra artisti ”outsiders” e gli ‘‘insiders”, ossia tra le nuove leve artistiche (a qualsiasi titolo) e i nomi già inseriti e affermati nel sistema; questa infelice comunione ha spinto i luoghi dell’arte a tramutarsi, da depositi del gusto e dell’estetico, in sorta di Merzbau, ossia magazzini all’interno dei quali ammassare suppellettili da esporre all’occasione.
È in questo senso che il museo -tanto per citare l’istituzione cardine e la più critica al momento- va assumendo sempre più le sembianze di un centro commerciale, un non-luogo la cui utilità è stata degradata da tempio – in cui spazio e tempo contemplativi convivevano in rapporto reciproco scanditi dallo sguardo curioso ed estatico dell’osservatore – a incunabolo di attività ricreative e ristorative per un visitatore fugace e distratto, disperso tra la folla che quotidianamente invade questi spazi.
Il modello di museo inteso come ”polo attivo” ipotizzato da Alexander Dorner sarebbe efficace.
Secondo l’idea di Dorner il museo dovrebbe essere inteso come una centrale elettrica in continuo movimento; un luogo in cui forze eterogenee si incontrano e si confrontano, mettendosi in continua discussione le une con le altre, scacciando l’idea di museo come ”ammasso di reliquie”.
Un’idea originale a applicabile se non andasse a scontrarsi con una realtà drastica e culturalmente povera sia sul piano dell’offerta che su quello della ricezione.
Una vasta quantità di eventi si susseguono a ritmo incalzante. Ben venga! Se l’organizzazione, tuttavia, non fosse scialba, rapida, inconsistente.
Poche opere -le ragioni della cui scelta, come mistici misteri eleusini, rimangono celate ai profani- vengono ”assemblate” insieme sulla presunta linea di una tematica che nulla spiega quale sia il fine verso il quale si protende.
Mostre a tema che divengono diletto e svago di una ”massa (nella interpretazione gramsciana) tramutata in folla”, per le quali opere disparate vengono proposte come set fotografici.
Opere estirpate e ”deturpate” del loro essere, della loro aurea.
Un esempio per tutti: la mostra LOVE e la sua gemella, la recente DREAM, una ludica messinscena dal sapore pop che chiaramente focalizza l’attenzione sul problema.
Si pensi a Yayoi Kusama, degradata a ”quella degli specchi e dei puntini’‘, nonostante la grande artista abbia alle spalle mezzo secolo di onorata attività artistica.

Si respira in questi ”eventi” aggreganti un’aria di superficialità; un attraversare scomparti di opere senza nulla chiarire sul significato, sul senso ultimo di una determinata scelta.
Una sciatteria messa in atto per attirare. L’arte è oramai attrazione.
È un male contemporaneo il bisogno di stupire, di creare spettacolo, di offrire panem et circenses ad una massa eterogenea e incostante, svilita e svilente e sempre più difficile da saziare.
L’epoca contemporanea si snoda sull’estremizzazione, sul portare concetti, pensieri e riflessioni al limite del loro valore e significato.
Dal concetto di democrazia a quello di mercato, l’arte è la vetrina di questa superficialità che emerge dalle ceneri ancora ardenti di un malessere di fondo, causa anche della diffusa identificazione dei prodotti artistici con quelli delle immagini, mito e prodotto di una società di massa sin troppo amalgamata (cft. ‘‘L’immagine contemporanea tra etica, estetica e marketing’‘).
L’idea democratica secondo la quale a tutti ormai sembra tutto concesso, nel caso in questione ha assunto una svolta determinante, avviando una sorta di crossover in base al quale antico e moderno vengono miscelati non solamente in occasione delle mostre, ma anche dallo stesso pubblico, attirato in questa ”orgia di eventi spettacolari con cui si cerca di far amare la pittura ad un pubblico che non la ama” (P. Citati).
Picasso e Michelangelo, Basqiuat o Caravaggio nulla importa. L’importante è esserci.
Sembra essersi così portata a conclusione la parabola critica alla società dei consumi messa in atto dalla cultura Pop, nonché si è radicalizzata su posizioni estreme la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte. Sopravvivono l’immagine e i simulacri spettacolari che attorno ad essa si vanno costruendo e realmente virtualizzando. Ma dell’arte poco resta, se non il nome e un vago ricordo che assume le sembianze di un’idea.
Scansata l’arte, è l’idea il vero prodotto, non solo da offrire, ma anche da vendere.
L’arte contemporanea, fondata sul mercato delle opere, è stata ridotta a mercimonio di orpelli e qualsiasi miserabile produzione venga pagata -da chi la produce- per essere affissa alla parete, senza alcun criterio critico o strategia di diffusione seria che possa giustificarne la messa in circolazione.
Si può attribuire la colpa a qualcuno?
È possibile, e quasi lecito, ordinare una piramide di responsabilità.
Al vertice vi sono le istituzioni: dalla politica alla dirigenza, sino alla critica.
LE ISTITUZIONI
Le politiche in materia sono molto restrittive della libertà d’azione dei vari direttori dei musei, costretti a sottostare, talvolta, a veri e propri diktat ministeriali; una legislazione che limita la libera circolazione delle opere o, al contrario, la incoraggia in maniera sconsiderata, non tenendo conto dei possibili danni derivanti dal trasporto, sistemazione e condizioni ambientali di manufatti molto delicati (come avvenne ad esempio in occasione dell’Expo di Milano, per il quale si chiese di esporre capolavori della nostra tradizione nel padiglione italiano, in conseguenza della qual decisione si sollevò una vera e propria protesta).
La logica del marketing è pronta a surclassare il valore non solo etico, ma anche materiale delle opere, a deturparne il contesto e la dignità in nome dello showbusiness, della remunerazione in termini di prestigio, affluenza e ovviamente denaro.
Stesso discorso vale per le fondazioni, sempre più inclini a sorvolare la tutela del nome dell’artista e pronte a cederne le opere e l’immagine per il proprio tornaconto, degradando l’artista, il suo nome e le sue opere a mero prodotto.
Sullo sfondo la debolezza della critica, della curatela e degli stessi studiosi, ”tacciati di sterile erudizione e di colpevole passività: sono solo presenze egoiste e altezzose, incapaci di adeguarsi alle tecniche di comunicazione di massa”. Una sentenza , questa di Montanari e Trione, che fotografa lapidariamente il collasso di uno dei pilastri su cui si regge l’edificio del mondo dell’arte.
La critica, in particolar modo, è assente.
Nessuna voce autorevole, nessuno in grado di saper valorizzare l’opera d’arte spingendosi oltre un mero giudizio, perlopiù pilotato da ragioni pubblicitarie.
Nessuna analisi sull’artista e il suo tempo; nessun rapporto viene approfondito rispetto ad un lavoro che ormai si va sempre più riducendo a produzione.
La critica d’arte si perde tra i trafiletti giornalistici e le sintesi imposte dalla cultura web di molti blogger, che impone una semplicità di linguaggio e una chiarezza lessicale che possa essere sfruttata e compresa da tutti. Forse troppi.
La critica opera una recensione. Non sa offrire nulla di più.
Dobbiamo davvero cedere sotto i colpi di questa ”depressione dei valori intellettuali”(P. Valéry)?
Alla base della piramide collochiamo due figure particolari, vittime e carnefici in questo vero e proprio stupro di massa commesso ai danni di questa Lucrezia violata, quale è l’Arte.
Parliamo del pubblico e degli artisti.
IL PUBBLICO DELL’ARTE
La posizione del pubblico è controversa.
Realmente sembra di assistere a quella che Achille Bonito Oliva definisce ‘‘una morte vaporizzata del pubblico”, ossia al progressivo mutamento di interesse di questo e ad una sorta di suo coinvolgimento ambiguo.
È vero che è un pubblico istantaneo e che ha fatto della velocità il suo tempo di contemplazione.
È un osservatore impaziente, simile allo spettatore di cui parla Mordillat (vedi link precedente): ha bisogno costantemente del proprio giocattolo; ha una fame impaziente di immagini, di rincorrerle alla stessa velocità dello scorrere di una pagina social.
Il pubblico dell’arte è lo stesso che vive della dimensione della virtualità, della riproduzione tecnica dell’opera, della pubblicità pedissequa e volta a presentare lo spettacolo dell’evento come tappa imprescindibile del percorso di vita.
È uno spettatore che cerca nella dimensione museale l’angolo di svago, la piattaforma di visibilità che lo faccia sentire parte della folla e al di sopra di ogni altro individuo della massa che ne resta fuori.
La cultura rende chic e slegati dall’ordinaria monotonia.
Ma nello stesso istante in cui è lo spettacolo e non l’insegnamento che prende il sopravvento, quanto vale sentirsi alienati dal resto di una società che si pensa di rifuggire?
Punti di vista che si incrociano con quello illuminante di Perniola, secondo cui il boom turistico ha condotto ad una fruizione superficiale e frivola delle opere, divenute indiscriminatamente oggetto di un’attenzione insipiente e insulsa.
<<Così la visita a un museo o un qualsiasi luogo dotato di speciali caratteristiche non è più il risultato di una scelta individuale motivata da un interesse, da un desiderio, o anche da una curiosità, ma un compito da eseguirsi passivamente, perché compreso nel pacchetto turistico del consumatore>>.
Ciò che caratterizza il visitatore contemporaneo non è la cultura, ma il culturale, vale a dire una predilezione per la quantità anziché per la qualità.
Di questa quantità vuole sentirsi parte attiva, testimonianza fisica.
Sta prevalendo non a caso, di recente, una strana tendenza.
Un articolo apparso recentemente sul web intitolava con gaudio: ”Il pubblico diventa arte”.
Il riferimento è a quella ridicola tendenza a voler sponsorizzare mostre, eventi o gli stessi spazi espositivi utilizzando come stratagemma il fotografare i visitatori intenti ad osservare le opere.
Niente di più misero, se non fosse che il pubblico non è parte di nulla se non di una continua campagna pubblicitaria volta a mettere in risalto il senso di piacere che una visita a quel luogo procura nel visitatore (tradotto in termini semplici: ”guarda anche tu quante persone frequentano questo luogo. Vuoi essere l’unico a perderti questi occasione?”).
È un circo mediatico che offre a questo pubblico ingenuo tutte le bizzarrie che possono scaturire dalla mente manageriale dei curatori: danze, buffet, vernissage, musica e intrattenimenti ludici.
Anche in questo caso l’Arte è lo scenario che fa da pendant a questo sciacallaggio mediatico.
GLI ARTISTI.
Per affrontare il discorso relativo agli artisti prendiamo in esame due affermazioni.
La prima è di Jeff Koons, secondo cui ”l’arte non consiste nel fare un quadro, ma nel venderlo”.
L’altra è ancora di Perniola, il quale riconosce che l’atto dell’arte non è più la fabbricazione di un artefatto che si possa designare come opera, ma una riduzione dell’arte ad un’azione infima che alla lunga risulta frustrante e nei confronti della quale non può esercitarsi operazione alcuna che non sia di mera documentazione.
Partiamo dall’affermazione di Koons.
È indubbio che qualsiasi opera realizzata abbia come fine ultimo il lucro, il guadagno. È altresì vero che dietro ogni opera vi è una circolazione di denaro.
L’artista è manipolato in tal senso. Egli pur di vendere ha l’onere in primo luogo di trovare chi lo presenti, chi curi il suo profilo e il suo lavoro.
Per ricavare denaro l’artista deve prima ”vendere” la sua opera affinché sia venduta.
È degradante, inoltre, vedere artisti accontentarsi di esporre in piccole mostre insieme ad altri artisti. La sua rimarrà un’opera tra le tante e la soddisfazione gli deriverà da una vendita sporadica e dalla menzione nel giornale provinciale.
Il problema di fondo è quella democratizzazione in nome della quale tutti sono ammessi ad entrare nel sistema (pagando sovente l’obolo al Caronte istituzionale che lo accoglie nelle spire illusorie di sogni di gloria).
Sarebbe necessario rivalutare la figura dell’artista.
Basta davvero definirsi ”artisti” per essere tali?
Non è sufficiente prendere un pennello e imbrattare una tela; non è sufficiente assemblare oggetti e sostenere di aver creato un’installazione artistica.
L’impegno, lo studio, la pratica: questi fattori sono imprescindibili e non serve un percorso accademico seguito da un titolo su carta; sarebbe sufficiente una preparazione da autodidatta.
Quello dell’artista è un mestiere e non mera passione e sin quando non si provochi una profonda cesura e una vera censura si tratterà solamente di illudere dilettanti allo sbaraglio.
Il nomadismo è sfociato in una diaspora prolifica di capi senza tribù. L’autonomia dell’artista si disperde in un bordello di opere senza patria e protettore.
Bisogna rivalutare il passato e prenderlo a spunto per il presente; e non si tratta solamente di una rilettura della tradizione artistica passata, ma studiare vicende e meccanismi che hanno permesso il progredire di movimenti, il loro sviluppo e il loro successo.
Il vero artista deve ribellarsi a questo sistema. Prometeo pagò a caro prezzo il furto del fuoco per donarlo all’uomo, eppure quest’ultimo ne trasse giovamento.
L’artista deve essere un redivivo Prometeo! Che sfidi pure il sistema!
Così avvenne nel 1863, quando un gruppo di artisti, rifiutati dal Salon ufficiale, organizzarono una esposizione autonoma, indipendente – Le Salon des Refusés– in cui esposero molti degli esponenti di quello che sarà il movimento impressionista. Questi artisti proponevano un’arte autonoma, slegata dalla tradizione accademica e questo evento non solo fu un’occasione per portare alla luce le nuove ricerche in campo artistico, ma fu oggetto di una critica molto feroce.
Lo stesso avvenne nel 1864 con la costituzione della Societé des atistes indépéndants.
Si deve avere il coraggio di rischiare per sapersi proporre, lottando contro ogni logica mercantilistica, di marketing e di divismo che già ha mietuto le sue vittime.
Rivalutare i manifesti artistici anche può essere una soluzione.
Aderire ad un manifesto non significa vincolarsi ad uno stile, adoperare tecniche simili. Aderire ad un manifesto significa aderire ad un’idea, ad una comune linea di pensiero che trovi espressione in simili (non identici) linguaggi artistici.
Questo significa attingere al passato, consapevoli di rischiare, di essere audaci nell’azzardare, nel ricercare supporti esterni che possano con forza scardinare lo status quo e ridonare carattere alla produzione artistica.
Bisogna recuperare l’aura sacra e abbandonare l’idea che tutto può essere arte e tutti possono diventare artisti. Si cade nel patetico se si vuole continuare a portare avanti questa battaglia e sbandierarla come vittoria di Pirro.
Purtroppo Duchamp è stato una sorta di Crono: ha partorito un’idea tanto geniale quanto micidiale. È il padre e assassino della contemporaneità.
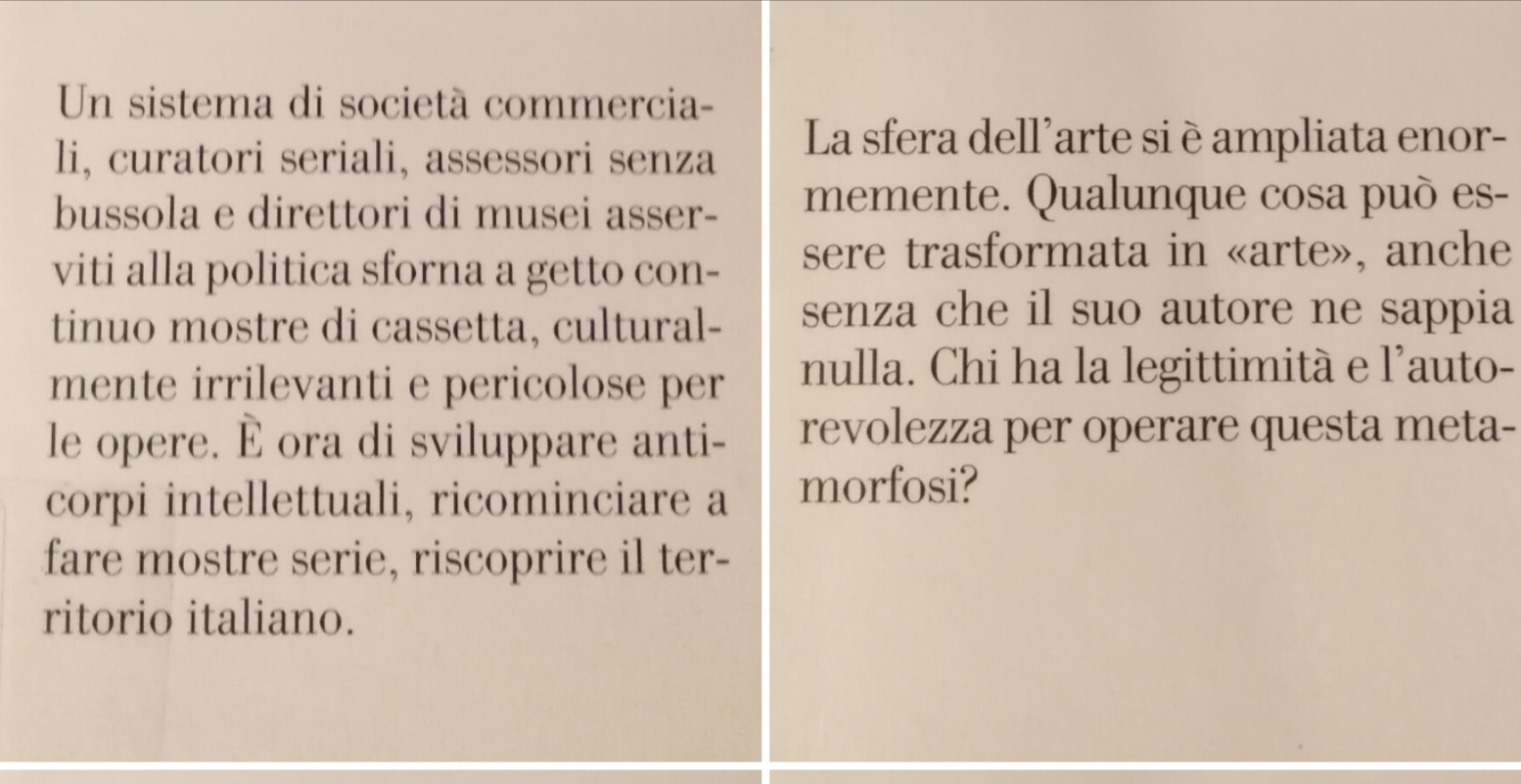
CONCLUSIONE.
Tanti i carnefici contro un’unica vittima, l’Arte.
L’arte rischia di perdere la sua dignità. Cosa significa?
Agnes Heller dedica delle pagine molto interessanti relative al concetto di dignità dell’opera d’arte, partendo dalla distinzione kantiana tra autonomia e dignità per giungere al riconoscimento dell’opera come persona, propria del pensiero di Adorno e Lukàcs.
Parlare di dignità dell’opera d’arte significa riconoscere questa -e di conseguenza l’artista- come persona e come tale, in base alla morale kantiana, va rispettata, ossia va trattata non solamente come mezzo, ma anche come fine.
Ciò significa che l’opera d’arte non un semplice oggetto, ma ha un suo spirito.
Tale spirito si manifesta nella sospensione momentanea dell’uso, ossia nell’alienazione dell’oggetto da quello che è l’uso per l’appunto, per elevarsi verso la dimensione contemplativa.
L’arte è tale perché oltre che un mezzo ha anche il fine dell’appagamento estetico ed estatico dell’osservatore.
È questo il punto sul quale bisogna riflettere e rileggere l’opera della Heller.
La filosofa riconosce che tutto questo è possibile se s’insegna all’osservatore ad apprezzare, a valorizzare e soprattutto a guardare con occhio critico ed estetico -un’estetica che coniughi oggettivo e soggettivo-. Oggigiorno, tuttavia, chi è in grado di assolvere a questo compito?
Se è vero che lo statuto della dignità dell’opera d’arte si fonda sul riconoscimento che le deriva dall’osservazione e dalla contemplazione, quali sono i criteri in base ai quali stabilire se quell’opera è arte?
È veramente necessaria solo l’osservazione? Il pubblico moderno sa osservare o si limita solo a vedere?
La realtà è che ha ragione Bonito Oliva: il riconoscimento della dignità dell’opera d’arte è subordinata al numero della folla. Il numero è la chiave di legittimazione del riconoscimento di un artista.
Questo accade perché l’istituzione non sa istruire, non è in grado di insegnare il valore della critica e non è capace -più che altro non vuole- di operare una selezione culturale in nome della sopravvivenza della Cultura. Non c’è dialogo, ma solo una conversazione unidirezionale. L’istituzione parla, ma non ammette contraddittorio. Il pubblico tace in ossequio.
Tra il pubblico e le istituzioni permane un baluardo difficile da espugnare.
Così il pubblico rimane escluso dalla tavola rotonda degli insiders istituzionali, appagati e crogiolati nella loro torre d’avorio vanagloriosa e babelica, non rendendosi neanche conto che il terreno sotto i loro piedi sta franando.
Ridonare dignità all’Arte significa in primo luogo restituirla nelle mani di chi è in grado di operare in suo nome, di assolvere le funzioni utili alla sua custodia e valorizzazione e strapparla dalle mani dei rapaci manager, bravi nelle loro operazioni mercantili, forse interessati; non basta l’interesse e l’economia serve nella misura in cui si possa garantire una circolazione volta ad istruire e non ad imbambolare le scimmie.
L’arte non è una fiera di paese. Non è marketing.
Se gli artisti e il pubblico non si oppongono a tutto questo, il rischio è di ritrovarsi davanti a puri oggetti, privi di spirito e dunque semplici mezzi.
A quel punto si dirà di aver passato una domenica in un circo; che lo spettacolo era ben organizzato; che avrete conversato senza dialoghi; che la sala era decorata con bei quadri.
D’altronde come ha fatto notare Guy Debord, la modernità è il topos in cui tutto viene vissuto come rappresentazione infinita.
-A. Celletti
PER APPROFONDIRE:
-A. BONITO OLIVA, L’arte oltre il Duemila, in G.C.ARGAN, L’Arte Moderna, 1770-1970, ed. Sansoni, 2002
-A. HELLER, La dignità dell’opera d’arte, ed. Irruzioni, Vignate (MI), 2017
-T. MONTANARI, V. TRIONE, Contro le mostre, ed. Einaudi, Torino, 2017
-M. PERNIOLA, L’arte espansa, ed. Einaudi, Tornino, 2015
-A. VETTESE, L’Arte contemporanea, ed. Il Mulino, 2012
